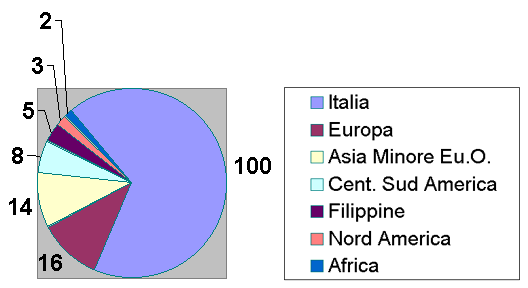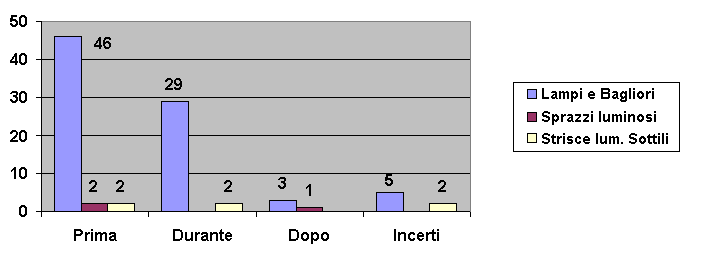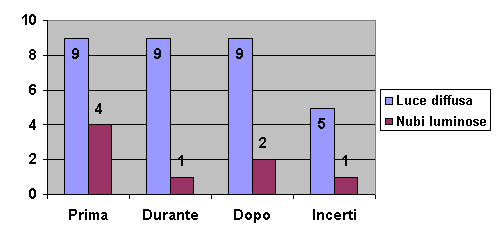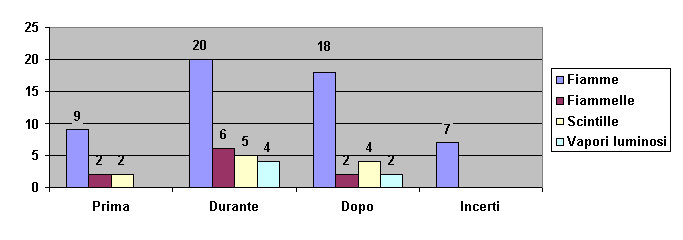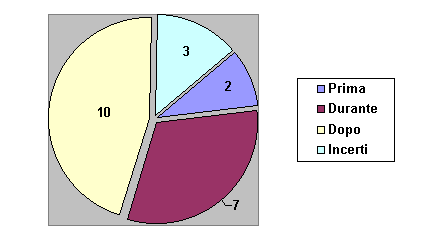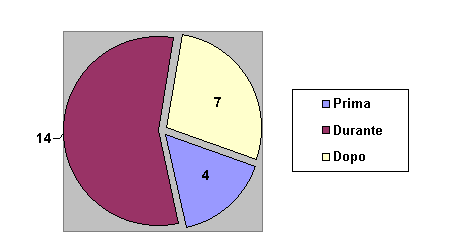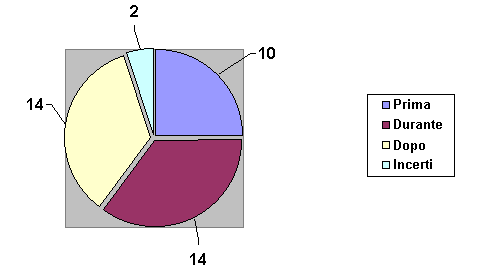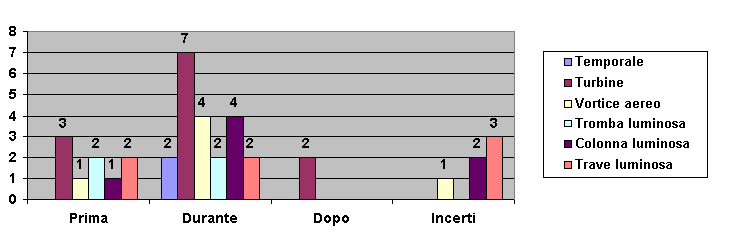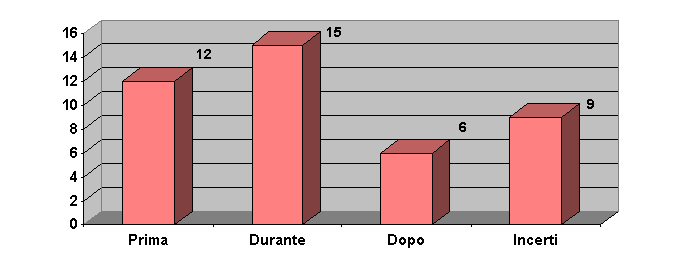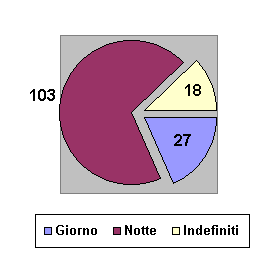|
Introduzione alle luci
sismiche
di Massimo Silvestri
max.silve@libero.it
Bologna, Settembre 1999 -2001
|
|
 6.
Ignazio Galli e la raccolta di fenomeni luminosi che accompagnano il
terremoto
6.
Ignazio Galli e la raccolta di fenomeni luminosi che accompagnano il
terremoto
A Ignazio Galli si deve il primo catalogo mai stilato sui fenomeni
luminosi connessi ai terremoti. Nato a Velletri nel 1841, sacerdote e
professore in scienze naturali, si interessò ai vari aspetti
della natura stimolandolo a scrivere decine di articoli e trattati,
pubblicati anche su riviste scientifiche estere. I suoi maggiori
interessi, che si riflessero anche in una maggiore produzione di
contributi, s’incentrarono sulla sismologia, la geofisica, la
meteorologia e l’ottica atmosferica. Fu tra i primi in Italia,
se non il primo, ad interessarsi di fulmini globulari, raccogliendo e
studiando decine di casi; s’interessò di aloni solari,
piogge anomale, rumori provenienti dall’atmosfera e dal
sottosuolo e di luci sismiche; inoltre condusse studi nel campo della
botanica e della musicologia. Morì agli inizi del 1920
[49].
Il fatto che fosse innanzi tutto un sacerdote, gli permise di
accedere a diversi archivi ecclesiastici, da cui recuperò
racconti e testimonianze, provenienti dalle varie missioni sparse nel
mondo, riguardanti i temi da lui studiati e attraverso la fitta
corrispondenza che intrattenne con altri religiosi italiani,
poté disporre di una rete di contatti attraverso la quale
raccolse informazioni pertinenti alle sue ricerche.
Il suo apporto nel campo della sismologia culminò nello studio
dei fenomeni luminosi causati dai terremoti. Raccolse e
analizzò parecchie testimonianze provenienti da luoghi e
periodi storici differenti; la somiglianza dei vari racconti, il
ricorrere d’eventi luminosi simili in terremoti distanti fra
loro, sia nello spazio che nel tempo, lo convinsero della
realtà del fenomeno. Dopo una prima esposizione della sua
ricerca al Congresso dei Naturalisti Italiani tenutasi a Milano nel
1907, pubblicò il suo massimo contributo alla comprensione di
questo fenomeno nel 1910 col titolo "Raccolta e classificazione dei
fenomeni luminosi osservati nei terremoti", in cui vennero riportati
tutti i casi da lui censiti, con un'analisi finale del fenomeno
indicandone le caratteristiche peculiari.
All'uscita di quest'opera, in seno alla comunità scientifica
si scatenò una accesa disputa fra chi, assieme al Galli,
reputò il fenomeno reale e meritevole di studio e chi, invece,
lo ritenne privo di fondamento. In tal senso è indicativo
l'intervento del prof. Agamennone; reputa l'opera del Galli
meritevole e degna di nota, in quanto pone l'accento su un fenomeno
che più volte si è presentato nel corso della storia e
che nessuno aveva ancora indagato con dovizia; ma osserva,
però, che i vari casi riportati non costituiscono una prova
esaustiva dell'esistenza del fenomeno, in quanto le emissioni
luminose possono essere attribuite a fattori esterni al terremoto,
come bagliori causati da incendi lontani, fulmini e lampi dovuti a
temporali oppure, per le testimonianze recenti, imputabili a
scintille e scariche dovute a rotture o cortocircuiti di linee
elettriche o telegrafiche (verso la fine del 1800, inizi '900 molte
grandi città conobbero l'uso dell'energia elettrica come fonte
d’illuminazione); senza contare quei casi in cui il panico
suscitato dalle scosse possa aver determinato l’osservazione di
fenomeni inesistenti. Agamennone cita il fatto che, recandosi egli
stesso a studiare il terremoto che colpì Bisignano il 3
dicembre 1887, pochi giorni dopo l’evento, raccolse notizie
riguardanti l'apparizione di una colonna di fuoco ma, dopo una
minuziosa analisi, arrivò a stabilire che il fenomeno fu
osservato da una sola persona isolata, e ne ricavò
l'impressione che si trattasse di un avvenimento poco credibile (tra
l'altro questo caso non è citato nella raccolta del Galli).
Anche dopo il sisma calabrese del 8 settembre 1905, (nella raccolta
del Galli risultò come il caso meglio documentato sia per
qualità, che per quantità di dati raccolti) egli si
recò in zona per studiare gli eventi, ma le notizie
riguardanti i fenomeni luminosi furono talmente insufficienti e
discordanti da far dubitare dell’oggettività del
fenomeno.
Quello che risulta inconcepibile (secondo la mia opinione) è
che già da molto tempo, prima dell’avvento del Galli, gli
eruditi erano a conoscenza di fenomeni luminosi (fuochi e fiamme)
fuoriuscenti dal terreno, anche in assenza di terremoti, come
riportato dal prof. Bombicci nel suo trattato (che riprende e amplia
i contenuti del libro del prof. Bianconi " Storia naturale dei
terreni ardenti, dei vulcani fangosi, delle sorgenti infiammabili,
dei pozzi idropirici, e di altri fenomeni geologici operati dal gas
idrogene e dell’origine di esso gas "), in cui vengono citati
casi avvenuti nel territorio emiliano romagnolo e in zone limitrofe.
Dalle esplosioni di gas (grisou) nelle miniere di Bisano, lungo la
valle dell’Idice, alle emanazioni gassose che a volte produssero
fiammate di 3 metri d’altezza nella valle del Reno, presso
Riola, alle centinaia di fiammelle viste ardere nell’aprile del
1879 a Greccia (Lizzano in Belvedere), ai fuochi di Pietramala e di
Barigazzo prodotti dalla fuoriuscita di gas combustibile dal
sottosuolo; tutte testimonianze delle potenzialità presenti
nella litosfera di produrre fenomeni luminosi e che rendono
incomprensibili le posizioni sostenute dai detrattori del Galli.
Ancora oggi, all’interno della comunità scientifica, vi
sono ricercatori che negano la realtà delle EQLs adducendo,
come spiegazioni per quei casi in cui sono riportate delle
testimonianze, le medesime motivazioni viste precedentemente [47,
48].
Ma ora ritorniamo all’opera del Galli e vediamo nel dettaglio
ciò che raccolse e a quali conclusioni pervenne. La raccolta
è composta da 148 casi, distribuiti su un arco di tempo che va
dal 89 a.C. al 1910. La suddivisione per periodi storici risulta:
|
Casi fino al X sec.
|
9
|
|
Casi dal X sec. fino a tutto il XV
sec.
|
4
|
|
Casi nel XVI sec.
|
4
|
|
Casi nel XVII sec.
|
15
|
|
Casi nel XVIII sec.
|
37
|
|
Casi nel XIX sec.
|
74
|
|
Casi nel XX sec.
|
5
|
La suddivisione per località:
|
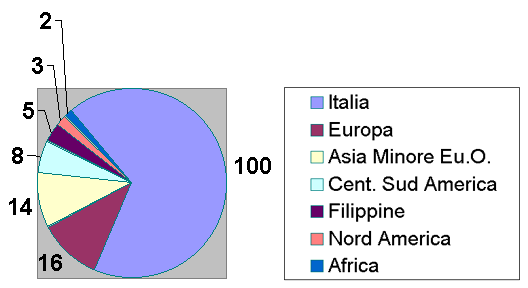
|
|
Località:
|
Nr.
casi
|
perc. %
|
|
Italia:
|
100
|
67,57 %
|
|
Europa:
|
16
|
10,81 %
|
|
Asia Minore e Europa
Orientale:
|
14
|
9,46 %
|
|
Centro e Sud America:
|
8
|
5,40 %
|
|
Filippine:
|
5
|
3,38 %
|
|
Nord America:
|
3
|
2,03 %
|
|
Africa:
|
2
|
1,35 %
|
Come si evince dalla tabella precedente, il catalogo riunisce i
dati provenienti da tutto il mondo anche se la maggioranza sono
d’origine italiana ed europea. Le testimonianze temporalmente
più recenti sono logicamente le migliori, per informazioni e
ricchezza di particolari, in quanto raccolte da sismologi intervenuti
sul luogo del sisma o da personaggi degni di nota che le inoltrarono
a ricercatori e studiosi interessati al problema. Alcuni episodi, per
stessa ammissione del Galli, sono semplici racconti, che presi
separatamente hanno scarso valore scientifico, se non quello di
testimoniare che qualcosa di anomalo è avvenuto; ma inseriti
in un contesto più ampio, con altri episodi meglio
documentati, anche queste semplici notizie diventano significative,
sottolineando nel complesso la realtà del fenomeno.
Analizzando i 148 casi possiamo operare una prima classificazione
in base alla forme assunte dalle EQLs, riconducibili a 4 gruppi
fondamentali:
- luci e bagliori diffusi istantanei,
- luci diffuse e nubi luminescenti con lunghi tempi di
persistenza,
- fiamme, fiammelle e nebbie luminescenti,
- forme strutturate con capacità di spostamento e
tempi di vita apprezzabili (globi, travi, colonne e trombe
luminose).
 Luci
e bagliori istantanei
Luci
e bagliori istantanei
In questo insieme sono raggruppati quei fenomeni ottici con
modalità di apparizione istantanea o di breve durata, che i
testimoni percepiscono come lampo o bagliore diffuso, i quali
illuminano repentinamente il cielo, senza che sia possibile
determinarne il punto d'origine. Queste luminescenze possono essere
paragonate a quei bagliori che di tanto in tanto illuminano il cielo
nelle limpide serate estive. Nella loro istantaneità, queste
manifestazioni luminose possono raggiungere intensità tali da
permettere ai testimoni, nel cuore della notte, di discernere ogni
più piccolo particolare nell’ambiente che li
circonda.
Sia per l’istantaneità degli eventi, che per il fatto che
la maggioranza delle testimonianze raccolte non aveva, inizialmente,
lo scopo di fornire dati qualitativi sul fenomeno, non sempre vengono
menzionate le eventuali colorazioni assunte da queste luminescenze.
Comunque, nei pochi casi (insufficienti per stilare una statistica)
in cui furono riferiti i colori, questi furono il bianco, il giallo
oppure il rosso.
Dalla casistica si desume che questa categoria di luci può
venire ulteriormente suddivisa in 3 sottoclassi, a seconda delle
indicazioni contenute nelle testimonianze: lampi e bagliori,
sprazzi luminosi e strisce luminose sottili.
Un dato interessante è rappresentato dal tempo di apparizione
di questi fenomeni rispetto al manifestarsi della scossa: 54,35% dei
casi si verifica prima, il 33,7% durante e il 4,35% dopo, con un 7,6%
di fenomeni di cui non è specificato il tempo di
apparizione.
Come si evince dalle percentuali, le luci di questo genere sono
percepite maggiormente prima e durante il sisma (per un totale del
80,05% di tutti i casi riportati), rispetto a quelli avvenuti dopo o
incerti.
Grafico e tabella: luci istantanee e la loro distribuzione
temporale:
|
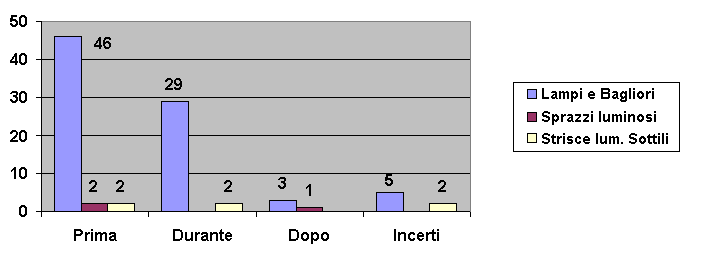
|
|
|
Prima
|
Durante
|
Dopo
|
Incerti
|
Totale
|
|
Lampi e bagliori
|
46
|
29
|
3
|
5
|
83
|
|
Sprazzi luminosi
|
2
|
-
|
1
|
-
|
3
|
|
Striscie luminose
sottili
|
2
|
2
|
-
|
2
|
6
|
|
Totale
|
50
|
31
|
4
|
7
|
92
|
|
%
|
50,35
|
33,7
|
4,35
|
7,6
|
100
|
N.B. Per evitare equivoci o erronee computazione, quando ci si
rivolge ai 148 casi catalogati da I. Galli, si intendono le
testimonianze di eventi sismici (quindi 148 terremoti), in cui
vengono riportati uno o più fenomeni luminosi riconducibili a
una o più classi di luci; se invece, come nel caso su
menzionato, si descrivono tipologie di fenomeni luminosi indicandone
ad esempio la frequenza, rappresentano il computo totale o parziale
di quel genere di emissione calcolato su tutti i fenomeni di quel
tipo all'interno dei 148 eventi sismici catalogati.
Alcuni esempi:
Il 22 gennaio 1892, le zone da Roma a Velletri e da Campobasso a
l’Aquila furono colpite da una forte scossa durante la notte.
Diversi testimoni, nelle varie zone, riferirono di aver visto un
intenso lampo nell’istante della scossa. Uno di questi, che si
trovava in camera, afferma che il lampo era così intenso da
permettergli di distinguere ogni particolare della stanza, nel minimo
dettaglio. Il 18 dicembre del 1897, la zona di Città di
Castello, Monte Nerone e dintorni furono colpite dal terremoto.
Alcuni testimoni riferiscono di aver visto un lampo alcuni istanti
prima del sisma, mentre diverse ore prima furono viste delle strisce
di fuoco attraversare il cielo sopra Monte Nerone in senso
orizzontale. Il fenomeno delle strisce infuocate si ripresentò
sul Monte Nerone, il 27 dicembre dello stesso anno, alcune ore prima
del sisma.
Nel terremoto che colpì l’Emilia il 4 marzo 1898, venne
riferito di un lampo che precedette l’arrivo della scossa.
Citando le parole del prof. Pio Benassi che si interessò ai
fatti:
"A S. Michele di Torre ed a Torrechiara parecchie persone, le
quali si trovavano per istrada, affermano con giuramento d’avere
osservato un lampo improvviso, simile a quelli che si scorgono nelle
calde sere d’estate in fondo all’orizzonte: del che
rimasero meravigliati, non parendo loro quella una giornata ed una
stagione da lampi, perciò supposero si potesse trattare di
qualche temporale dietro l’Appennino ed aspettavano il tuono:
invece udirono il rombo e si sentirono traballare."
Bisogna ricordare che in questi casi, alcuni colleghi del Galli
sollevarono la questione che si potesse trattare o di temporali
concomitanti al sisma o bagliori causati dalla rottura di conduttori
elettrici. Gli esempi contenuti nel catalogo lasciano poco spazio a
queste interpretazioni in quanto, sia l’arco di tempo coperto,
sia le testimonianze rilasciate dagli osservatori portano ad
escludere queste ipotesi o comunque a far sì che un buon
numero di osservazioni resista a queste interpretazioni.
 Luci
diffuse e nubi luminescenti con lunghi tempi di persistenza
Luci
diffuse e nubi luminescenti con lunghi tempi di persistenza
In molti terremoti viene riportato dai testimoni l’aver
osservato in cielo una luce diffusa rossastra che precedette e
accompagnò per tutto il tempo l’arrivo della scossa.
Questo fenomeno venne riscontrato anche a sisma concluso. Con le
stesse modalità di apparizione e medesima colorazione
rossastra vengono riportati, anche se in numero minore, casi di nubi
luminescenti. I meccanismi alla base di questa luminescenza diffusa
possono essere diversi:
una luminescenza intrinseca dell’aria eccitata dal terremoto
(vedi le ipotesi esposte precedentemente); oppure un fenomeno di
rifrazione/diffusione della luce solare mediante particelle di
polvere e vapori sollevatesi dal suolo scosso dal terremoto (anche se
alcuni casi si verificarono di notte è plausibile che il
fenomeno sia avvenuto nell’alta atmosfera ancora attraversata
dai raggi solari).
Grafico e tabella: Luci diffuse e nubi luminescenti e loro
distribuzione temporale
|
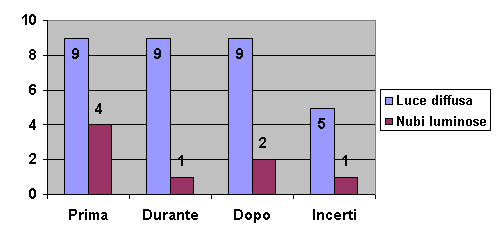
|
|
|
Prima
|
Durante
|
Dopo
|
Incerti
|
Totale
|
|
Luce diffusa
|
9
|
9
|
9
|
5
|
32
|
|
Nubi luminose
|
4
|
1
|
2
|
1
|
8
|
|
Totale
|
13
|
10
|
11
|
6
|
40
|
|
%
|
32,5
|
25
|
27,5
|
15
|
100
|
Alcuni esempi:
A Manila il 4 marzo 1862, il missionario p. Saderra Maso riferisce
di una scossa molto forte e dello strano aspetto del cielo (5:30 del
pomeriggio) per la colorazione assunta dalle nuvole.
Sempre dalle Filippine, p. Saderra riferisce di un altro terremoto
abbattutosi nella zona di Mindanao il 18 giugno 1878, dove
l’atmosfera assunse una strana colorazione rossa.
Il 12 marzo 1873 le Marche e l'Umbria furono sconvolte da un forte
terremoto, nel quale furono osservati vari tipi di fenomeni luminosi
fra i cui una luce rossa diffusa, che precedette l'arrivo del sisma.
Durante i rovinosi terremoti che colpirono la Calabria e la zona di
Messina, l'8 settembre 1905 e il 28 dicembre 1908, vi fu una vera
esplosione di fenomeni ottici che accompagnarono le varie scosse fra
i quali, luminescenze diffuse e persistenti, e nuvole infuocate nel
cielo.
 Fiamme,
fiammelle e altre emissioni luminose
Fiamme,
fiammelle e altre emissioni luminose
Nei 148 casi raccolti da I. Galli, vi è una ricca casistica
di fenomeni luminosi riconducibili alla fuoriuscita di gas e ad altri
materiali aeriformi dal sottosuolo. Inoltre sono forniti gli indizi
che spiegano la formazione d’alcune luci osservate quasi sempre
a livello del suolo. Si ha l'evidenza di una cospicua serie di
testimonianze riguardanti fiamme, fiammelle e vapori luminescenti
visti fuoriuscire dal terreno o lungo le pareti esterne ed interne
delle abitazioni al momento della scossa.
Osserviamo ora, tramite l'analisi eseguita dal Galli, l'incidenza del
fenomeno rispetto al periodo di comparsa del sisma.
Grafico e tabella: Fiamme, fiammelle e altre emissioni e loro
distribuzione temporale
|
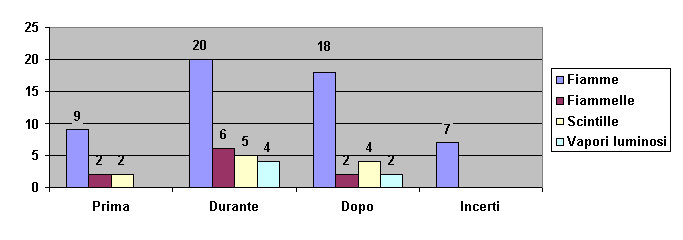
|
|
|
Prima
|
Durante
|
Dopo
|
Incerti
|
Totale
|
|
Fiamme
|
9
|
20
|
18
|
7
|
54
|
|
Fiammelle
|
2
|
6
|
2
|
-
|
10
|
|
Scintille numerose
|
2
|
5
|
4
|
-
|
11
|
|
Vapori o nebbie
luminose
|
-
|
4
|
2
|
-
|
6
|
|
Totale
|
13
|
35
|
26
|
7
|
81
|
|
%
|
16,05
|
43,21
|
31,1
|
8,64
|
100
|
Da notare che il massimo lo si ha in concomitanza della scossa
(43,21% dei casi computati), in numero minore dopo (32,1%) per poi
diminuire drasticamente prima della scossa (16,05%). La frequenza di
comparsa confermerebbe l'ipotesi che queste luci siano legate alla
liberazione di sostanze gassose presenti nella crosta terrestre e che
raggiungerebbero l'atmosfera grazie alle fratture operate dal
terremoto. I meccanismi che rendono luminosi i gas possono risiedere
(come descritto in precedenza) in processi combustivi o
chemiluminescenti (visto, comunque, che la questione a tutt'oggi
è ancora incerta con molti interrogativi irrisolti, possono
esserci processi non ancora evidenziati dai ricercatori che
permettano di ampliare il numero dei meccanismi in gioco). A favore
della prima ipotesi (autocombustione dei gas), vi sarebbero diversi
indizi, come l'osservazione di densi vapori e fumo a forma di nuvola
o di colonna, visti sprigionarsi dal terreno e alzarsi in cielo
accompagnati, a volte, da fiamme e fiammelle; la loro distribuzione
temporale è simile a quella osservata precedentemente per le
fiamme.
Grafico e tabella: Fumo e vapori e loro distribuzione
temporale
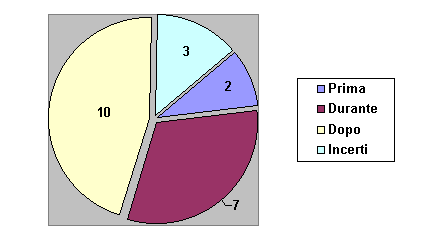
|
|
|
Prima
|
Durante
|
Dopo
|
Incerti
|
Totale
|
|
Fumo e vapori
|
2
|
7
|
10
|
3
|
22
|
|
%
|
9,1
|
31,82
|
45,45
|
13,63
|
100
|
I testimoni di alcuni terremoti affermarono di aver percepito
folate d’aria calda alle gambe o in altre parti del corpo. In
altri casi venne riportato l’arrivo di vento caldo in
concomitanza col sisma, perfino sul mare; oppure di emanazioni di gas
estremamente caldi che procurano profonde bruciature nella
vegetazione circostante, pur non essendo notata alcuna fiamma. Si
riportano 25 casi con indicazione del tempo di apparizione:
Grafico e tabella: gas e vapori caldi
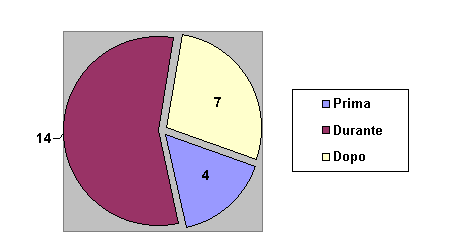
|
|
|
Prima
|
Durante
|
Dopo
|
Totale
|
|
Gas e vapori caldi
|
4
|
14
|
7
|
25
|
|
%
|
16
|
56
|
28
|
100
|
Significative sono le testimonianze riguardanti le esalazioni
nauseanti percepite durante i vari terremoti. Si avvertì
spesso l'odore di zolfo, sostanze bituminose e anidride solforosa,
sia nei vari luoghi colpiti dal sisma che nell'acqua sorgiva e in
almeno 3 casi sul mare. Nei 40 casi in cui si percepirono tali
esalazioni, 38 contengono le indicazioni riguardanti il periodo di
comparsa, permettendo la stesura di una prima analisi. La
distribuzione temporale dei casi è pressoché costante
nelle tre fasi del sisma.
Grafico e tabella: odori di zolfo, bitume e altri gas.
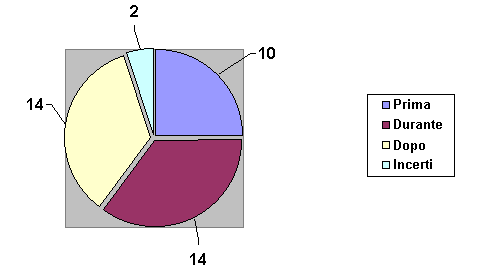
|
|
|
Prima
|
Durante
|
Dopo
|
Incerti
|
Totale
|
|
Esalazioni sulfuree e
bituminose
|
10
|
14
|
14
|
2
|
40
|
|
%
|
25
|
35
|
35
|
5
|
100
|
In altri casi non furono registrate solamente le semplici
esalazioni nauseanti di questi composti, ma anche l’osservazione
delle sostanze che li generarono. Nel terremoto di Palermo del 1
settembre 1726, oltre alla già citata colonna luminosa vista
precipitare in mare, fu osservato dello zolfo bruciare all'interno
delle fenditure apertesi nel terreno. In altri episodi si videro
fuoriuscire sostanze liquide o semi liquide, bituminose (petrolio)
che infestarono l'aria con le loro esalazioni.
Rari gli episodi di esalazioni d'anidride carbonica che porterebbero
malesseri e difficoltà respiratorie. Vi sono alcuni esempi non
catalogati nei 148 casi, in quanto non presentano fenomeni luminosi,
che risultano di notevole valore per la testimonianza che
apportano.
Il viaggiatore e naturalista tedesco A. von Humboldt riferì
che, il 16 novembre 1827 durante il sisma in Nuova Grenada (Colombia)
nella valle del fiume Magdalena, la fuoriuscita di una grande
quantità di anidride carbonica asfissiò una moltitudine
di serpenti, topi e altri animali che abitualmente vivono nel
terreno. Durante la serie di scosse che fece tremare la zona a sud
ovest dei monti Albani, dal 21 maggio al 6 dicembre 1829 (ne vennero
contate 248 nell’arco di sole 24 ore); in alcune grotte, ad
Albano Laziale, l’esalazione d’anidride carbonica uccise
gli animali che vi dimoravano, spense i lumi accesi e causò
malesseri nella popolazione.
Anche le nebbie luminescenti viste a livello del suolo rappresentano
un aspetto interessante del fenomeno. Testimonianze provenienti da
luoghi e tempi diversi rendono il fenomeno plausibile anche se
estremamente raro (6 casi in tutto). Mentre per tutti i fatti
precedentemente esposti si può supporre un processo di
autocombustione, per le nebbie luminose la questione si complica.
Analizzando le varie testimonianze riguardanti i vapori luminescenti,
se ne ricava l'impressione di non trovarsi di fronte ad un fenomeno
di autocombustione, in quanto non vengono notati incendi causati dal
passaggio di queste masse luminose, nè tantomeno la percezione
di calore dal fenomeno (come nel caso già citato del terremoto
andaluso del 1884 dove, toccando il terreno con i piedi, si
osservò lo sprigionarsi di una luce fosforica); e nemmeno
l'elevato tempo di vita del fenomeno congiunto alla capacità
di mantenersi in forma compatta senza disperdersi, depone a favore di
questa ipotesi (nel caso andaluso la nebbia luminosa si scisse in due
masse e seguì il propagarsi del terremoto in due direzioni
differenti, oppure nel caso calabro del 1905, dove diversi testimoni
videro una specie di nuvola fosforescente avanzare da SW e al momento
della scossa avvicinarsi al suolo per poi svanire).
Molto probabilmente ci troviamo al cospetto di fenomeni
chemiluminescenti o di particolari processi non ancora indagati;
c'è da notare, comunque, che i casi riportati sono in numero
così esiguo e che le relative descrizioni così scarne o
insufficienti, da non permettere la formulazione di una valida
ipotesi a supporto di questi eventi.
Vediamone in generale alcuni esempi:
Il 25 agosto 1613 la città di Naso, in Sicilia, fu colpita dal
terremoto; non furono notati fenomeni ottici, in quanto il sisma
avvenne in pieno giorno; ma i fenomeni secondari furono tali da far
supporre la loro presenza. In un terreno, vicino alla città,
si aprì una spaccatura larga 3 metri dalla quale
fuoriuscì fumo nero e caldo che danneggiò la
vegetazione circostante.
Durante il rovinoso terremoto di Lisbona, nel giorno
d’Ognissanti del 1755, furono osservati diversi fenomeni
luminosi, fra i quali il levarsi di fumo e grandi fiamme nell'oceano
Atlantico. I terremoti bolognesi del 1779 e 1780 vennero ricordati
non solo per le innumerevoli volte in cui si sentì tremare il
terreno sotto i piedi, ma anche per gli incredibili effetti luminosi
dai quali furono accompagnati; si riferirono fiamme e fiammelle
uscenti dal terreno, folate d'aria calda che investirono le
popolazioni, il levarsi di fumo e vapori, odori nauseanti di zolfo e
vapori luminescenti. A Siena, il 3 gennaio 1781, fiamme altissime ed
esalazioni nauseanti accompagnarono le diverse scosse che si
abbatterono sulla zona.
Il 5 febbraio 1783, nelle zone colpite dal sisma in Calabria e in
Sicilia settentrionale, si osservarono delle fiamme uscire dal suolo,
vapori caliginosi ammantare la zona di Messina e un diffuso odore di
bitume e zolfo. Il 6 febbraio 1783 nel territorio di Reggio C. e
Messina vennero contate circa 140 scosse nell'arco delle 24 ore.
Oltre all'episodio del capitano della nave svedese, riportato in
precedenza (vedi EQL in mare); i pescatori della zona di Reggio
notarono che la sabbia presso la riva del mare era caldissima e che
in molti punti nei terreni limitrofi fuoriuscivano delle fiamme.
Catanzaro, il 28 marzo 1783, fu colpita, nelle ore notturne, da una
forte scossa; i testimoni osservarono la presenza di numerose fiamme
alzarsi dal suolo e, passata la prima scossa, apparire in cielo una
fiamma biancastra obliqua, che perdurò per circa 2 ore. Oltre
a questi fenomeni il giorno precedente, in una sorgente d'acqua
potabile, comparve uno sgradevole sapore di zolfo che la rese
imbevibile e ripugnante all'olfatto.
 Masse
luminose compatte
Masse
luminose compatte
Vediamo ora la casistica e la relativa analisi condotta da I.
Galli riguardante quelle luci con apparente struttura, quali le
colonne e travi infuocate, le trombe luminose e i globi di luce.
Questa casistica rappresenta la parte più enigmatica e
complessa dell'intero corpo osservativo. Dalle caratteristiche
mutevoli, queste masse luminose possono muoversi lentamente oppure a
velocità incredibili; capaci di compiere tragitti rettilinei
oppure zigzagare evitando gli ostacoli incontrati sul loro cammino e
presentando tempi di vita incredibilmente lunghi.
Per quanto riguarda trombe, colonne e travi luminose, il Galli
espresse l'opinione che si trattasse di medesimi fenomeni percepiti
in posizioni diverse. Nelle loro apparizioni, queste luci furono
spesso accompagnate da fischi e sibili che in una certa misura li
resero simili ai moti vorticosi del vento. Questo suggerì al
Galli l'idea che tali fenomeni ottici fossero legati a quegli stessi
gas che in condizioni di quiete determinano l'insorgere di fiamme e
fiammelle; mentre in altre condizioni, aspirati da vortici e turbini
atmosferici, creino quei fenomeni descritti come trombe, colonne e
travi incandescenti.
Ignazio Galli osservò un’analogia fra la distribuzione
temporale di queste luci e quella dei vortici d'aria, turbini
atmosferici, colpi di vento e alcuni temporali rispetto alle varie
fasi
del terremoto.
Il motivo per cui si tenne in debito conto queste perturbazioni
atmosferiche fu determinato da quei rapporti in cui i testimoni
osservarono tali eventi apparire nello stesso istante
della scossa, tenere eventualmente la medesima direzione di
spostamento e sparire in concomitanza col cessare del sisma. Da qui
l'ipotesi di un processo fisico comune alla base di questi eventi
così apparentemente diversi fra loro; ma vediamo i dati
desunti nei 148 casi catalogati.
Grafico e tabella comparativa
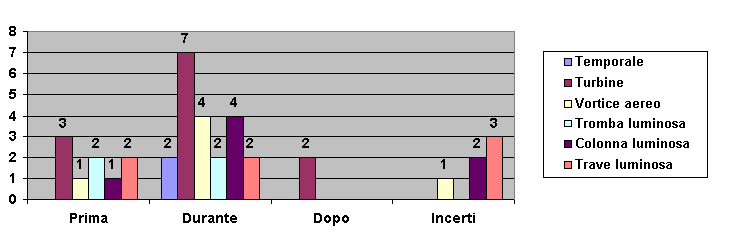
|
|
|
Prima
|
Durante
|
Dopo
|
Incerti
|
Totale
|
|
Temporale
|
-
|
14
|
14
|
2
|
40
|
|
Turbine
|
3
|
7
|
2
|
-
|
12
|
|
Vortice aereo
|
1
|
4
|
-
|
1
|
6
|
|
Tromba luminosa
|
2
|
2
|
-
|
-
|
4
|
|
Colonna luminosa
|
1
|
4
|
-
|
2
|
7
|
|
Trave luminosa
|
2
|
2
|
-
|
3
|
7
|
|
Totale
|
9
|
21
|
2
|
6
|
38
|
Sembrerebbe che questa classe di fenomeni così eterogenei,
siano in realtà originati da un qualche processo comune,
facendo sì che in concomitanza col sisma si abbia il massimo
delle apparizioni; un numero minore di casi prima della scossa, per
poi ridursi a soli 2 eventi dopo. A mio giudizio l’ipotesi
risulta forzata, in quanto il numero di casi a disposizione sui quali
ragionare sono in numero esiguo per poterne trarre delle conclusioni
credibili e nel contempo alcuni casi di colonne e travi infuocate mal
si adattano a questa ipotesi.
Come riuscirebbe una massa di gas incandescente a mantenersi compatta
pur muovendosi attraverso l’atmosfera, a velocità spesso
elevate, come riferito dai testimoni? Come riescono i fenomeni ottici
ad autosostenersi per lungo tempo senza esaurirsi (vi è un
caso in cui una trave brillò in cielo per 45 minuti), nel caso
fossero semplici masse di gas infuocato?
E come spiegare il caso di Palermo del 1726, in cui si videro due
colonne di luce precipitare in mare rendendo luminosa la superficie
dell’acqua per un tempo considerevole?
Domande che per ora non trovano risposta, se non quella dettata dal
buon senso, che un medesimo fenomeno luminoso, somigliante per forma
e colore, potrebbe trarre origine da processi fisici differenti
(finora non si è mai accennato ai colori, in quanto le
testimonianze riportano termini, quali "luminosi", "infuocate", "di
fuoco" oppure "fosforiche"; troppo generici per poter eseguire
un’analisi dettagliata).
Alcuni casi di colonne luminose riportate dal Galli e confrontate
con altre testimonianze, fanno sorge il ragionevole dubbio di
trovarsi fra le mani non più un semplice, per modo di dire,
fenomeno di forma ben delineata e spazialmente delimitata (che se si
presenta verticalmente lo si definisce colonna e orizzontalmente
trave), bensì ad un fascio di luce che dal terreno si innalza
in cielo con un effetto simile a quello prodotto da un faro elettrico
indirizzato verso l’alto. In questo caso la colonna di luce
differirebbe dall’idea che si potrebbe trarre, dall’ipotesi
precedentemente formulata, di forme ben definite (ellissoidi,
cilindrico &endash; coniche) che nel loro muoversi in cielo vengono
percepite in maniera differente.
Alcuni esempi:
Nella notte fra il 20 e 21 luglio 1399, in concomitanza con la
scossa, apparve in cielo una grande trave luminosa che procurò
notevole spavento fra la popolazione bolognese. Di maggior vigore fu
il fenomeno osservato il 26 luglio 1805, nel terremoto che coinvolse
la Campania e il Molise; simile ad una trave, fu vista sollevarsi
dalla zona di Bojano, sorvolare tutto il territorio fino a Isernia e
qui precipitare contro un muro di rinforzo producendo un foro ovale
lungo 16 palmi per 8 (circa 4 metri per 2 metri). La sera seguente il
terremoto (27 luglio), nella zona di S.Giorgio (Benevento) fu
osservata in cielo una trave infuocata luminosissima, dalle
dimensioni apparenti di 100 palmi per 1 (circa 25 metri per 0,25),
velocissima nel suo moto, si dileguò lasciando dietro a
sé una leggera scia di colore mutevole (cangiante).
Il 22 marzo 1821, nell'istante della scossa che colpì
gravemente l'Umbria, si vide una colonna di fuoco uscire dal fiume
Cannara per poi gettarsi, dopo aver sorvolato la città di
Rieti, nel lago Cantalice. In Calabria, nella notte tra il 24 e il 25
aprile 1836, verso mezzanotte moltissimi animali mostrarono segni di
inquietudine e il mare divenne repentinamente agitato e tempestoso;
su di esso, nella località Calopezzati, apparve una trave
infuocata e nello stesso istante si sentì un fortissimo rombo
e sopraggiunse un’intensa scossa sismica.
 Globi
luminosi
Globi
luminosi
Passiamo ad esaminare il fenomeno più enigmatico di tutta
la casistica del Galli, quello che può essere definito il
mistero nel mistero.... le apparizioni dei globi luminosi.
Essi si manifestarono in moltissimi terremoti, creando stupore e
meraviglia fra i testimoni, per alcune loro caratteristiche
comportamentali che li contraddistinsero dai restanti fenomeni
luminosi. Dalla casistica raccolta, si evince che il massimo delle
apparizioni si hanno durante le scosse; in numero minore prima, per
poi ridursi notevolmente dopo.
Grafico e tabella globi luminosi
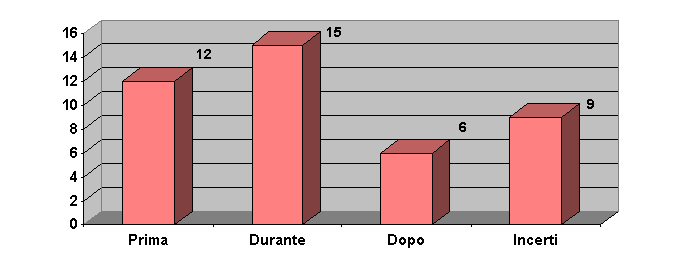
|
|
|
Prima
|
Durante
|
Dopo
|
Incerti
|
Totale
|
|
Globi luminosi
|
12
|
15
|
6
|
9
|
42
|
|
%
|
28,57
|
35,71
|
14,29
|
21,43
|
100
|
Dal comportamento bizzarro furono, visti sorgere almeno 7 volte
dalla terra e 3 volte dal mare; muoversi in linea retta oppure
zigzagando; a livello del suolo o in alto nel cielo, oppure spostarsi
all'interno di abitazioni completamente chiuse, sparire
silenziosamente oppure con un tuono fragoroso; dileguarsi lasciando
dietro di sé un odore di zolfo, oppure interagire con uomini e
cose. Per quanto riguarda i colori assunti dal fenomeno, vige quanto
detto per le colonne e travi precedentemente analizzate, e
cioè che i testimoni si riferirono a queste sfere con termini
troppo generici per ricavarne una valida statistica quali luminose,
infuocate, di fuoco e fosforiche; facendo presagire in linea di
massima i colori e le sfumature che vanno dal rosso al giallo. Queste
caratteristiche, come osservò a suo tempo il Galli, li rendono
estremamente simili ai fulmini globulari e altre osservazioni
posteriori (non contenute in questa raccolta), fanno sorgere il
legittimo dubbio di osservare il medesimo fenomeno con la differenza
che, in un caso, le forze promotrici risultano localizzate nella
litosfera e nell'altro, invece, nell'atmosfera. Fisici atmosferici
del calibro di J.E. McDonald e ricercatori interessati ai fulmini
globulari si dedicarono allo studio delle EQLs per poter svelare
questi legami; nè si possono trascurare le scoperte compiute
dalla comunità scientifica riguardanti alcune interazioni fra
caratteristiche elettriche della ionosfera e i terremoti. In alcuni
casi venne osservata una variazione dello strato di ionizzazione, con
ripercussioni sulle trasmissioni radio (onde lunghe) e in diversi
casi, monitorando le caratteristiche elettriche della banda di
Schumann, se ne osservò un incremento nella frequenza e
nell’ampiezza, nel periodo che precedette il terremoto; ma solo
per quelli avvenuti sulla terra e non in mare.[32]
Vediamo ora alcuni casi.
Dal giugno 1779 al maggio dell'anno successivo, Bologna venne
colpita da una serie continua di terremoti, anche forti, che non
provocarono notevoli danni, ma che mostrarono un numero e una
varietà tale di fenomeni luminosi da essere annoverati fra
quegli esempi che già da soli testimonierebbero la
realtà del fenomeno. Il 7 giugno 1779 a Bologna vi furono
parecchie scosse nell'arco della giornata, accompagnate durante le
ore serali dalla comparsa di moltissimi globi di fuoco, visti volare
sulla città. Per tutta l'estate e l'autunno del '79, sempre
nel bolognese, le varie scosse furono accompagnate dalla presenza di
globi luminosi che apparirono sia di giorno, sia di notte; produssero
sibili e rumori nei loro rapidi spostamenti e in alcuni casi se ne
osservarono alcuni con un diametro apparente maggiore di 2 piedi
(circa 80 cm).
I globi luminosi, assieme ad altri fenomeni ottici, fecero la loro
comparsa anche all'interno di camere completamente chiuse, aumentando
il mistero verso queste enigmatiche luci e gettando nel panico i
testimoni. Il 16 gennaio 1780 un esponente del corpo accademico
bolognese riferì che affacciandosi alla sua finestra, verso
mezzanotte, vide salire dal suolo un globo biancastro, informe, di
circa 3 piedi di diametro (1,20 m), il quale si portò sul
tetto della sua abitazione, da qui vagò per un certo periodo
nei dintorni e allontanandosi velocemente emise un forte sibilo.
Oltre ad essere di colore biancastro, dal corpo fuoriuscivano delle
punte acuminate e fu osservato per 16 &endash; 18 secondi prima che
sparisse dietro a delle case. Nell’istante in cui sorse dalla
terra non è dato sapere se vi fosse stata una scossa, ma da
altre fonti si apprende che in questo periodo vi furono parecchie
scosse di lieve intensità e comunque il fenomeno dei globi
luminosi è circoscritto solamente al periodo sismico del
1779-1780. Il 28 luglio 1799, la zona di Camerino e San Ginesio
furono colpite da una serie di terremoti; i primi scuotimenti furono
di lieve entità e non si notò nulla di strano se non un
aumento repentino di 7 gradi circa della temperatura. Durante la
notte si abbatté la scossa più forte dell’intera
serie, che non solo procurò notevoli danni ma fu accompagnata
da eventi incredibili. Comparvero fiamme e fiammelle in diversi
luoghi sia in aria che al suolo; furono osservate strisce luminose in
cielo e dei fuochi luminosi sulle cime degli alberi (fuochi di
Sant’Elmo). Sopra Camerino fu osservato, subito dopo il sisma,
un globo infuocato " tinto di vari colori ", salire in cielo
talmente velocemente che assunse la forma di colonna o ellissoide per
l’impressione che diede all’osservatore (o viceversa), e di
una luminosità tale che dalle colline prospicienti si videro
chiaramente le torri della città.
Non meno spettacolare fu ciò che accadde nei pressi di San
Severino dove un enorme globo di fuoco nel suo vagabondare si
avvicinò ad un olmo disseccandone la maggior parte delle
foglie, per poi finire la sua corsa su un capanno, usato come
deposito di lino e di fieno, incendiandolo completamente e
danneggiando gravemente altri magazzini nelle vicinanze.
Nella stessa nottata, il campanile dell’unica chiesa del
castello Cessapalombo venne colpito da un globo luminoso che
danneggiò la struttura muraria e produsse un foro circolare
nella cupola. Non fu migliore la sorte toccata alla torre campanaria
della Collegiata, presso San Ginesio, dove un globo luminescente
divelse e sospinse lontano una pesantissima struttura metallica. Si
narra infatti che in cima a detta torre fosse presente una struttura
di ferro composta da 4 aste piegate ad arco sulla cui sommità
era presente una palla di rame e una croce con banderuola,
dell’altezza di 3 metri. L’intera struttura pesava circa 4
quintali ed era fissata saldamente nei muri per una profondità
di 1,5 metri. All’atto della scossa, dal campanile si staccarono
diversi calcinacci che precipitarono ai piedi della torre, la
struttura metallica, invece, fu sbalzata nella piazza alla distanza
di circa 6 metri (i dotti del tempo osservarono che ciò era
contrario alla logica, in quanto doveva precipitare nello stesso
punto dei calcinacci) e prima che ciò accadesse dei testimoni
videro accendersi un globo infuocato sulla cima della torre che
accompagnò nella caduta l’ammasso metallico finché
non toccò il suolo.
(Può darsi che la caduta del castello metallico sia dipeso
dal terremoto e non dal fenomeno luminoso in sé, e dal momento
che questa scossa fu anticipata da altre, nell’arco della
giornata precedente, può darsi che quelle avvenute prima
possano aver danneggiato la struttura muraria e che l’ultima,
più intensa, abbia dato il colpo di grazia facendo crollare il
tutto. Per quanto riguarda il globo luminoso la sua apparizione
nell’istante della caduta può risultare indipendente dai
fatti che seguirono, oppure la luminescenza osservata non dipese dal
globo; bensì dal fuoco di Sant’Elmo, scariche elettriche
luminose che avvengono, guarda caso, sulla sommità di oggetti
acuminati quali pennoni di navi, alberi e campanili. Tra l’altro
i fuochi di Sant’Elmo furono visti in molti luoghi durante
questo terremoto a testimonianza di una (probabile) elevata
elettricità atmosferica. La questione che detta massa sia
caduta più lontano di quello che era logico aspettarsi
può trovare risposta in fatti analoghi accaduti in questo ed
altri terremoti, dove persone e cose, per l’energia liberata dal
sisma, furono sbalzati lontano dal punto in cui si trovavano. Tutto
questo però sono solo congetture personali e i fatti a nostra
disposizione sono quelli narrati dai testimoni con tutto quello che
ne consegue.)
La sera del 1 ottobre 1802 a Beauvois (Oise, Fr), poco dopo una
leggera scossa sismica, apparve un globo infuocato luminosissimo che
si mosse da est verso ovest e scomparve con una forte detonazione,
lasciando un persistente odore di zolfo. Brutta vicenda quella che
accadde ad un pastore, durante il sisma calabro dell’otto marzo
1832. La testimonianza raccolta dal canonico della zona dice:
"Il pastore Mussari di Panettiere (circondario di Cosenza)
è di ciò testimone quando osservando 4 globi di fuoco
mancò per la paura, e tanto più allorché li vide
a se avvicinare, uccidere una sua cavalla e lasciare lui
siffattamente malmenato da cadere sul suolo quasi privo di vita, e da
potere appena aprire i lumi alla luce nel giorno seguente."
(Fatto riferito anche da altri testimoni).
Il 20 e 21 marzo del 1861 a Mendoza (Argentina), diversi terremoti
turbarono la quiete della notte e un testimone riferì di aver
visto emergere alcuni globi infuocati dai piedi di un albero, ogni
fuoriuscita era accompagnata da una scossa. Del terremoto che
devastò la zona di Manila il 3 giugno 1863, proviene la
testimonianza di globi luminosi visti fuoriuscire dal mare. Fenomeni
simili a quelli riportati precedentemente, furono raccolti dal
sismologo Mercalli durante gli eventi del 28 luglio 1883 presso
l’isola di Ischia, dove alcune persone osservarono,
all’atto della scossa, l’emergere di globi infuocati in
diversi punti del mare.
La lungimiranza mostrata da I. Galli nel raccogliere e studiare
questi fatti viene magnificata dall’aver catalogato e analizzato
anche quei casi in cui apparvero nuove sorgenti d’acqua o
manifestazioni legate a quest’elemento che, come sappiamo dai
recenti studi, gioca un ruolo fondamentale nella formazione delle
EQLs.
Dei 148 casi di eventi sismici con annessi fenomeni luminosi, ve ne
furono 7 in cui si registrò la nascita di sorgenti
temporanee d’acqua sulfurea, di cui solamente in un caso
fu segnalato il fatto che fosse caldissima e contemporanea alla
scossa, mentre per i restanti 6 casi non viene specificato il periodo
di comparsa. In 3 casi l’acqua fresca di sorgente divenne calda
alcune ore prima del sisma e in un solo caso contemporaneamente alla
scossa. È riportato un solo caso di alti getti d’acqua
calda e salata, avvenuto 15 &endash; 20 minuti prima della scossa (e
che le crepe da cui fuoriuscirono i getti rimasero calde per diversi
giorni); si registrarono solo 7 casi di getti ad alta temperatura
contemporanei al terremoto.
Tabella riassuntiva:
|
|
Prima
|
Durante
|
Dopo
|
Incerti
|
Totale
|
|
Nuove sorgenti d'acqua
(temporanee)
|
1
|
-
|
-
|
6
|
7
|
|
Sorgenti già esistenti che da
fredde divennero calde
|
3
|
1
|
-
|
-
|
4
|
|
Getti d'acqua calda
|
1
|
7
|
-
|
-
|
8
|
|
Totale
|
5
|
8
|
-
|
6
|
19
|
Questi dati, pur risultando in numero esiguo e qualitativamente
carenti, forniscono una sommaria indicazione di un eventuale
meccanismo fisico alla base di questi fenomeni ottici.
La conclusione che si può trarre dalla lettura di questa
raccolta e dalle analisi condotte dal Galli, è che il fenomeno
è reale ed è connesso a diversi processi fisici
stimolati dagli eventi sismici. Si può obbiettare che la
raccolta è datata e in diversi casi qualitativamente
insufficiente; ciò corrisponde al vero e non bisogna
dimenticare che quest'opera ha ormai un secolo ed è quanto di
meglio si poté fare per quei tempi. Del resto le cose non sono
migliorate un gran ché col trascorrere degli anni nel resto
del mondo sul tema delle luci sismiche.
Da quanto mi è dato sapere, oltre a quello del Galli, sono
stati redatti solo pochi cataloghi e quasi tutti riguardanti eventi
locali (Musya nel 1932 con casistica giapponese, Huang e Hanzen nel
1980 con casi cinesi); la creazione di un catalogo a più ampio
respiro, che contenga il maggior numero di casi, se non tutti quelli
scoperti fino ad oggi, è un'esigenza sentita anche da quei
ricercatori impegnati in questa indagine, tanto da spingere il noto
scienziato P. Hedervari a sollecitare i vari colleghi a varare un
progetto di raccolta, catalogazione e studio di questo fenomeno su
scala mondiale.[50]
Ritornando alla raccolta di I. Galli, questa ha l'indiscutibile
valore di far emergere un dato fondamentale, ossia quello riguardante
il periodo di comparsa dei fenomeni luminosi rispetto agli eventi
sismici. Dall’analisi di questo particolare aspetto, si evince
che un elevato numero di fenomeni ottici fu osservato prima
dell’arrivo delle scosse e questo confuta, almeno per questi
casi, tutte quelle ipotesi che vogliono il fenomeno derivato da cause
psicologiche (stress e paura), da cortocircuiti e da riflessi di
incendi lontani.
In alcuni casi si potrebbe ravvisare nei cortocircuiti la spiegazione
più probabile, oppure ricondurli a normali temporali presenti
in zona, ma è anche vero che l'abbondante casistica presentata
dal Galli mostra che non tutti gli eventi si manifestarono
nell'ultimo scorcio del XIX secolo (o agli inizi del XX), quando
l'uso dell'elettricità iniziò a diffondersi presso le
grandi città; del resto esistono testimonianze provenienti da
zone rurali dove l’energia elettrica non era ancora arrivata e
si osservarono ugualmente delle luminescenze; nè è
plausibile ricondurli a banali temporali, in quanto molte
testimonianze contengono riferimenti indicanti la presenza di cieli
limpidi e sereni. Lo stesso dicasi per quegli eventi meteorici
concomitanti con i terremoti (globi di fuoco e meteore luminose), in
quanto se ammettessimo per un istante che tutti questi casi furono
reali meteore, diverrebbero incredibili queste continue coincidenze
fra rientri meteorici ed eventi sismici; senza considerare che molte
di queste manifestazioni furono viste fuoriuscire dal terreno e dal
mare. D’altronde, anche il fatto che su 130 casi indicanti
l’ora, 103 avvennero di notte e solamente 27 di giorno,
testimonia l’oggettività del fenomeno e la
disomogeneità è dettata dal fatto che la maggioranza
delle EQLs risultano luci di debole intensità, ed è per
questo che le ore notturne facilitano la loro osservazione [5, 7,
8].
Grafico distribuzione giornaliera (casi indicanti
l'ora):
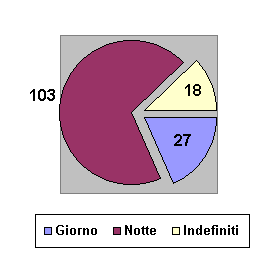
|
|
Giorno
|
Notte
|
Indefiniti
|
Totale
|
|
27
|
103
|
18
|
148
|
|
69,59 %
|
18,25 %
|
12,16 %
|
100 %
|
Tabella riassuntiva dei fenomeni luminosi osservati
|
|
Prima
|
Durante
|
Dopo
|
Incerti
|
Totale
|
|
Lampi e bagliori
|
46
|
29
|
3
|
5
|
83
|
|
Sprazzi luminosi
|
2
|
-
|
1
|
-
|
3
|
|
Strisce lumimose
sottili
|
2
|
2
|
-
|
2
|
6
|
|
Luce diffusa
|
9
|
9
|
9
|
5
|
32
|
|
Nubi luminose
|
4
|
1
|
2
|
1
|
8
|
|
Fiamme
|
9
|
20
|
18
|
7
|
54
|
|
Fiammelle
|
2
|
6
|
2
|
-
|
10
|
|
Scintille numerose
|
2
|
5
|
4
|
-
|
11
|
|
Vapori o nebbie
luminose
|
-
|
4
|
2
|
-
|
6
|
|
Globi luminosi
|
12
|
15
|
6
|
9
|
42
|
|
Totale
|
101
|
126
|
73
|
36
|
336
|
|
%
|
30,06
|
37,5
|
21,73
|
10,71
|
100
|
APPROFONDIMENTI SU IGNAZIO GALLI
[Bio-Bibliografia]
© Copyright: Massimo Silvestri - CISU-UDN
(1999)
itacomm.net
(2001-2002)
Quale espressione dell'attività intellettuale dell'autore,
questo materiale è protetto dalle leggi internazionali sul
diritto d'autore. Tutti i diritti riservati. Nessuna riproduzione,
copia o trasmissione di questo materiale può essere eseguita
senza il permesso scritto dell'autore. Nessun paragrafo e nessuna
tabella di questo articolo possono essere riprodtti, copiati o
trasmessi, se non con il permesso scritto dell'autore. Chiunque
utilizzi in qualsiasi modo non autorizzato questo materiale è
perseguibile a norma delle vigenti leggi penali e
civili.
For the Photographs:
© Copyright Steinbrugge Collection,
Earthquake Engineering Research Center, University of California,
Berkeley.